Oriana Fallaci, Maurizio Landini e il 7 ottobre 2025
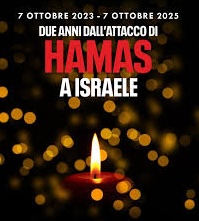 Sono passati due anni esatti dagli attentati che il 7 ottobre 2023 hanno colpito Israele, lasciando una scia di sangue e terrore difficile da dimenticare. Il mondo si è fermato, l’Europa ha osservato, spesso con il fiato corto e il coraggio dimezzato. Ma mentre la diplomazia ufficiale arrancava, la pace è arrivata, o almeno un fragile accordo, grazie ad un attore inaspettato: Donald Trump. È stato lui, con una mediazione silenziosa, ma decisa, a riportare le parti a un tavolo, spiazzando analisti e benpensanti. Una pace concreta, non imposta dalle piazze o dai proclami, ma costruita con la forza della realtà. E, intanto, in Italia, ci si è persi tra le macerie di una protesta senza visione. Mentre a Doha si firmavano accordi, qui si lanciavano slogan e sassi. Le vetrine rotte nelle città italiane non hanno fermato alcuna guerra, ma hanno messo a dura prova la convivenza civile. La cosiddetta “Flottilla della pace”, i cortei antagonisti, e le dichiarazioni infiammate di Maurizio Landini hanno aggiunto rumore, ma non soluzioni ed invece di costruire ponti, si sono alzati muri. E a questo punto vale la pena ricordarlo chiaramente che il compito di un sindacato è quello di tutelare i lavoratori, difendere i diritti, migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro e non trasformarsi in un partito mascherato, pronto a sindacare ogni mossa del Governo come se fosse un’opposizione politica alternativa. Un sindacato “vero” non si schiera nei giochi di potere, ma resta accanto ai lavoratori, senza agende ideologiche e senza incitare alla ribellione sociale fine a sé stessa. Ecco perché, oggi più che mai, le parole che Oriana Fallaci scrisse su Panorama il 18 aprile 2002 suonano come un colpo alla coscienza collettiva. Parole che parlavano di libertà, di indifferenza e di pericoli che si annidano nel silenzio colpevole delle società democratiche. Allora molti le giudicarono estreme, ma oggi, a distanza di oltre vent’anni, si rivelano semplicemente lucide. Fallaci non si limitava a commentare, ma avvertiva. Ci chiamava a non ignorare ciò che stava cambiando sotto i nostri occhi. E se oggi l’Italia è attraversata da un senso di smarrimento, da una politica sempre più gridata e da un’informazione polarizzata, è proprio perché troppo spesso si è scelto di non ascoltare. Di ridicolizzare chi invitava alla vigilanza, di confondere la militanza con la rabbia, la protesta con il vandalismo e la critica con il sabotaggio. Oriana Fallaci ci ha lasciato una lezione scomoda, ma fondamentale, che la libertà non si difende con i cortei che devastano le città, né con i sindacati trasformati in tribune ideologiche, ma si difende con la coerenza, il pensiero critico e il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, e senza ambiguità, e senza paura. E se oggi il mondo è un po’ più vicino alla pace, non è merito di chi ha alzato la voce per farsi notare, ma di chi ha avuto la forza di agire in silenzio e con determinazione. Anche questo, in fondo, è un messaggio che la Fallaci avrebbe approvato.
Sono passati due anni esatti dagli attentati che il 7 ottobre 2023 hanno colpito Israele, lasciando una scia di sangue e terrore difficile da dimenticare. Il mondo si è fermato, l’Europa ha osservato, spesso con il fiato corto e il coraggio dimezzato. Ma mentre la diplomazia ufficiale arrancava, la pace è arrivata, o almeno un fragile accordo, grazie ad un attore inaspettato: Donald Trump. È stato lui, con una mediazione silenziosa, ma decisa, a riportare le parti a un tavolo, spiazzando analisti e benpensanti. Una pace concreta, non imposta dalle piazze o dai proclami, ma costruita con la forza della realtà. E, intanto, in Italia, ci si è persi tra le macerie di una protesta senza visione. Mentre a Doha si firmavano accordi, qui si lanciavano slogan e sassi. Le vetrine rotte nelle città italiane non hanno fermato alcuna guerra, ma hanno messo a dura prova la convivenza civile. La cosiddetta “Flottilla della pace”, i cortei antagonisti, e le dichiarazioni infiammate di Maurizio Landini hanno aggiunto rumore, ma non soluzioni ed invece di costruire ponti, si sono alzati muri. E a questo punto vale la pena ricordarlo chiaramente che il compito di un sindacato è quello di tutelare i lavoratori, difendere i diritti, migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro e non trasformarsi in un partito mascherato, pronto a sindacare ogni mossa del Governo come se fosse un’opposizione politica alternativa. Un sindacato “vero” non si schiera nei giochi di potere, ma resta accanto ai lavoratori, senza agende ideologiche e senza incitare alla ribellione sociale fine a sé stessa. Ecco perché, oggi più che mai, le parole che Oriana Fallaci scrisse su Panorama il 18 aprile 2002 suonano come un colpo alla coscienza collettiva. Parole che parlavano di libertà, di indifferenza e di pericoli che si annidano nel silenzio colpevole delle società democratiche. Allora molti le giudicarono estreme, ma oggi, a distanza di oltre vent’anni, si rivelano semplicemente lucide. Fallaci non si limitava a commentare, ma avvertiva. Ci chiamava a non ignorare ciò che stava cambiando sotto i nostri occhi. E se oggi l’Italia è attraversata da un senso di smarrimento, da una politica sempre più gridata e da un’informazione polarizzata, è proprio perché troppo spesso si è scelto di non ascoltare. Di ridicolizzare chi invitava alla vigilanza, di confondere la militanza con la rabbia, la protesta con il vandalismo e la critica con il sabotaggio. Oriana Fallaci ci ha lasciato una lezione scomoda, ma fondamentale, che la libertà non si difende con i cortei che devastano le città, né con i sindacati trasformati in tribune ideologiche, ma si difende con la coerenza, il pensiero critico e il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, e senza ambiguità, e senza paura. E se oggi il mondo è un po’ più vicino alla pace, non è merito di chi ha alzato la voce per farsi notare, ma di chi ha avuto la forza di agire in silenzio e con determinazione. Anche questo, in fondo, è un messaggio che la Fallaci avrebbe approvato.

 A Roma c’è un quartiere che si sente tradito. Si chiama Infernetto, e oggi vive con l’incubo di diventare il nuovo deposito dei rifiuti domestici della Capitale. Sì, proprio così, il Sindaco Gualtieri e la sua giunta comunale sembrano intenzionati a collocare una discarica di rifiuti urbani in una zona residenziale, abitata da famiglie, bambini e anziani. La vicenda del cantiere Ama di via Ermanno Wolf Ferrari è esplosa come una bomba. Da settimane, l’area è ferma, transennata, ma senza controllo. Secondo diverse fonti, sarebbero stati rinvenuti materiali pericolosi, tra cui, si mormora, perfino amianto. Eppure dal Campidoglio, ancora silenzio. Nessuna nota ufficiale, nessun sopralluogo del sindaco, nessuna spiegazione pubblica ai cittadini che vivono ogni giorno con la paura di respirare sostanze nocive. Il quartiere è in subbuglio. Le famiglie si chiedono come sia possibile che in una zona densamente abitata, già provata da anni di incuria, si possa anche solo ipotizzare di collocare una discarica. E soprattutto, come sia stato possibile lasciare per oltre venti giorni il sito completamente abbandonato, esposto alle piogge, senza alcuna misura di sicurezza. È una fotografia impietosa di un’amministrazione che sembra disinteressarsi della salute pubblica, concentrata più sulle carte che sulle persone. Il gruppo capitolino e municipale di Forza Italia ha alzato la voce, parlando di un comportamento “superficiale ed irresponsabile” da parte del Comune. E annuncia battaglia con una richiesta di convocazione urgente della commissione Trasparenza, un esposto alla Procura della Repubblica, un’interrogazione municipale e una segnalazione alla Asl. L’obiettivo è chiaro dobbiamo capire chi ha deciso cosa, chi ha controllato e, soprattutto, chi non lo ha fatto. Perciò la politica, da sola, non basta. Perché la rabbia dell’Infernetto è reale, profonda e umana. I cittadini sono pronti a scendere in piazza, insieme alle associazioni e ai comitati di quartiere, per difendere il loro diritto a respirare aria pulita, a vivere in sicurezza, a non essere trattati come cittadini di serie B. Il sindaco Gualtieri e l’assessora Alfonsi devono risposte chiare per chi ha autorizzato il progetto della discarica? E quali siano stati i controlli ambientali? Cosa è stato trovato davvero nel terreno del cantiere Ama? E, soprattutto, perché il Comune non ha ancora sospeso i lavori fino a quando non saranno garantite condizioni di piena sicurezza? Roma non può più permettersi questa gestione opaca e distante. Il rispetto per l’ambiente e per le persone non può essere solo uno slogan da campagna elettorale. L’Infernetto merita trasparenza, dignità e tutela. Perché se il degrado diventa la regola e la sicurezza un optional, allora non è più una città, ma è una discarica morale e politica.
A Roma c’è un quartiere che si sente tradito. Si chiama Infernetto, e oggi vive con l’incubo di diventare il nuovo deposito dei rifiuti domestici della Capitale. Sì, proprio così, il Sindaco Gualtieri e la sua giunta comunale sembrano intenzionati a collocare una discarica di rifiuti urbani in una zona residenziale, abitata da famiglie, bambini e anziani. La vicenda del cantiere Ama di via Ermanno Wolf Ferrari è esplosa come una bomba. Da settimane, l’area è ferma, transennata, ma senza controllo. Secondo diverse fonti, sarebbero stati rinvenuti materiali pericolosi, tra cui, si mormora, perfino amianto. Eppure dal Campidoglio, ancora silenzio. Nessuna nota ufficiale, nessun sopralluogo del sindaco, nessuna spiegazione pubblica ai cittadini che vivono ogni giorno con la paura di respirare sostanze nocive. Il quartiere è in subbuglio. Le famiglie si chiedono come sia possibile che in una zona densamente abitata, già provata da anni di incuria, si possa anche solo ipotizzare di collocare una discarica. E soprattutto, come sia stato possibile lasciare per oltre venti giorni il sito completamente abbandonato, esposto alle piogge, senza alcuna misura di sicurezza. È una fotografia impietosa di un’amministrazione che sembra disinteressarsi della salute pubblica, concentrata più sulle carte che sulle persone. Il gruppo capitolino e municipale di Forza Italia ha alzato la voce, parlando di un comportamento “superficiale ed irresponsabile” da parte del Comune. E annuncia battaglia con una richiesta di convocazione urgente della commissione Trasparenza, un esposto alla Procura della Repubblica, un’interrogazione municipale e una segnalazione alla Asl. L’obiettivo è chiaro dobbiamo capire chi ha deciso cosa, chi ha controllato e, soprattutto, chi non lo ha fatto. Perciò la politica, da sola, non basta. Perché la rabbia dell’Infernetto è reale, profonda e umana. I cittadini sono pronti a scendere in piazza, insieme alle associazioni e ai comitati di quartiere, per difendere il loro diritto a respirare aria pulita, a vivere in sicurezza, a non essere trattati come cittadini di serie B. Il sindaco Gualtieri e l’assessora Alfonsi devono risposte chiare per chi ha autorizzato il progetto della discarica? E quali siano stati i controlli ambientali? Cosa è stato trovato davvero nel terreno del cantiere Ama? E, soprattutto, perché il Comune non ha ancora sospeso i lavori fino a quando non saranno garantite condizioni di piena sicurezza? Roma non può più permettersi questa gestione opaca e distante. Il rispetto per l’ambiente e per le persone non può essere solo uno slogan da campagna elettorale. L’Infernetto merita trasparenza, dignità e tutela. Perché se il degrado diventa la regola e la sicurezza un optional, allora non è più una città, ma è una discarica morale e politica.


